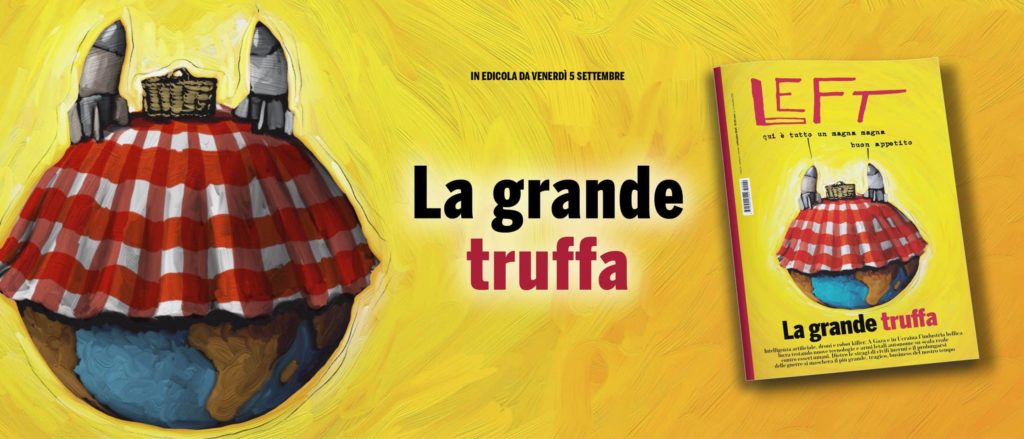Il paradigma della sicurezza nazionale e internazionale va rivisto. E dobbiamo investire nella pace, ecco come
Un mio articolo per il numero di settembre 2025 di Left
In un’epoca segnata da accelerazioni militari e da logiche geopolitiche in tensione, serve un’altra narrazione: quella della pace attiva, della sicurezza attraverso investimenti sociali, ambientali, sanitari, educativi e di cooperazione internazionale. Perché le attuali decisioni di militarizzazione e aumento delle spese militari volute dai governi ci porteranno solo maggiore sicurezza e il rischio di uno stato di guerra permanente. Il recente summit Nato e le élite europee sembrano intenti a pianificare una nuova corsa al riarmo. Nel vertice dell’Aja di fine giugno 2025 i 32 Paesi membri hanno concordato di aumentare la spesa militare entro il 2035 fino al 5 % del Pil: almeno il 3,5 % in «core military spending» (armi, mezzi, operazioni) e fino al 1,5 % in spese «di difesa e sicurezza correlate» (infrastrutture critiche, cyber, mobilità militare, resilienza). Anche l’Italia, con una spesa attuale attorno all’1,57 % del Pil (circa 35 miliardi di euro), si trova dunque ad affrontare un salto epocale: triplicare la spesa annuale fino a oltre 100 miliardi, con aumenti di 6-7 miliardi all’anno nei prossimi dieci. Il costo cumulativo stimato dall’Osservatorio Mil€x di questa scelta si potrebbe aggirare sui 700 miliardi per la sola parte “core”.
A questa prospettiva si deve aggiungere anche la proposta della Commissione europea – il piano “ReArm Europe” – che prevede investimenti fino a 800 miliardi per rafforzare la difesa e l’industria militare europea (con spese che andranno a pesare sui singoli Stati membri) oltre che la bozza di nuovo bilancio Ue per il periodo 2028-2034 che dovrebbe prevedere per il comparto difesa e spazio un totale di risorse a disposizione di 131 miliardi (cinque volte il settennato precedente!) con un contributo stimabile per il nostro paese di circa 2,4 miliardi l’anno (16,8 miliardi per sette anni) sempre secondo l’Osservatorio Mil€x.
Dati che, se messi in fila, risultano davvero impressionanti. Ma cosa ci dicono davvero? Quale può essere il significato sottostante e strutturale, al di là delle enormi cifre? La prospettiva di lungo periodo che se ne può trarre è quella di un trasferimento, nei prossimi decenni, di una quota rilevante se non enorme della nostra sovranità democratica e delle risorse pubbliche a favore degli interessi del complesso militare-industriale-finanziario. Il tutto a seguito della pressione delle lobby delle armi, delle strutture militari (e non) della Nato e cavalcando le richieste esplicite ed interessate di Trump e dei suoi sodali a favore di un riarmo spinto. Un aumento che (come abbiamo sperimentato negli ultimi decenni, già caratterizzati da un raddoppio della spesa militare mondiale) che di certo non aumenterà la sicurezza, ma ridurrà sensibilmente le risorse disponibili per la coesione sociale, il welfare, la sanità, l’istruzione, la lotta al cambiamento climatico, lo sviluppo sostenibile e la cooperazione internazionale.
Nel panorama europeo segnato da questa stagione di riarmo solo la Spagna ha rappresentato una rara, se pur parziale, eccezione. Mentre gli altri governi – Italia compresa – si sono allineati alle richieste dell’Alleanza atlantica e alle pressioni statunitensi, Madrid ha scelto di non impegnarsi sulle cifre previste dal nuovo target, ma solo confermare il percorso già avviato per raggiungere il 2% (e soprattutto le “capacità operative” che la Nato vuole) entro il 2029. Una posizione che, pur prevedendo comunque aumenti rispetto agli attuali livelli del bilancio per la Difesa, evita quantomeno l’escalation esorbitante di risorse l’obiettivo del 5% comporterebbe. Sánchez ha motivato questa scelta con la necessità di mantenere un equilibrio tra difesa e investimenti sociali, ricordando che la sicurezza di un Paese non può essere ridotta al mero potenziamento militare. Vedremo cosa succederà, ma nel contesto di un’Europa in cui l’unico dibattito possibile sembra essere quello appiattito sulla retorica infondata del riarmo, la Spagna è stata capace almeno di mandare un segnale politico: esiste un’alternativa alla militarizzazione totale, che passa per una concezione di difesa più ampia, orientata alla sicurezza condivisa e alla pace positiva.
Questa scelta non è priva di rischi sul piano diplomatico, ma apre uno spazio importante per chi, in Europa, chiede di ridiscutere il rapporto tra spesa militare e bisogni reali delle società, sottraendo la politica di difesa alla mera obbedienza a target imposti dall’alto. Al contrario, in un’Italia che nel 2025 prevede una spesa sanitaria di circa 136 miliardi e un budget dell’istruzione attorno agli 80 miliardi la spesa militare ipotizzata con questi nuovi target e pressioni esterne (senza dimenticare la spesa indiretta attraverso il bilancio Ue già segnalata) si avvicinerà per dimensioni – e in prospettiva supererà – quegli stessi capitoli essenziali per la vita delle persone. Non è una mera contabilità: è una scelta politica radicale. Stiamo parlando di numeri e cifre che sono neutri, non sono semplici scelte tecniche di bilancio: raccontano un cambio strutturale dell’economia, della società, della democrazia e persino della nostra idea di sicurezza. Impegnare settecento miliardi di euro nei prossimi dieci anni solo per il 3,5% di parte “core” delle spese militari, e aggiungere altri 17 miliardi nel prossimo ciclo settennale per contribuire al bilancio europeo della difesa e dello spazio, significa indirizzare il futuro di tutti verso una scelta che rischia di rendere più fragile il tessuto sociale, aumentare le tensioni internazionali e restringere gli spazi di democrazia partecipata. Al contrario scegliere di investire tali risorse nella sanità pubblica, nell’istruzione, nelle politiche ambientali, nella cooperazione internazionale e nella giustizia sociale significherebbe gettare le basi di percorsi concreti di pace positiva: non la sola assenza di guerra, ma la pace che nasce da diritti garantiti, pari opportunità, coesione e cura dei beni comuni. Investimenti positivi che sarebbero capaci di produrre da subito ritorni economici e sociali concreti, e potrebbero rafforzare in prospettiva la resilienza delle nostre società riducendo nel contempo le cause profonde dei conflitti globali. Ecco perché diventa cruciale la voce delle campagne globali come la Global campaign on military expenditures (Gcom) o Stop rearm Europe, e quella italiana Ferma il riarmo. Sono spazi di pressione democratica che, partendo dalla società civile, possono mettere in discussione l’allineamento cieco dei governi alle richieste della Nato, delle lobby delle armi e di leader che spingono per una militarizzazione senza limiti.
La Gcom promuove la riduzione coordinata delle spese militari a livello mondiale, chiedendo agli Stati di fissare tetti massimi, deviare fondi verso sanità, istruzione, ambiente e cooperazione, e garantire trasparenza nei bilanci della difesa. Stop rearm Europe mobilita reti di pace e società civile contro il piano Ue di massicci investimenti in industria e apparati militari, chiedendo di reindirizzare le risorse del bilancio europeo verso la transizione ecologica, la giustizia sociale e la diplomazia. La campagna Ferma il riarmo si oppone all’aumento record della spesa militare nazionale imposto da Nato e Ue, denunciandone i costi insostenibili (centinaia di miliardi nei prossimi anni) e promuovendo iniziative di pressione su Parlamento e governo per bloccare nuovi programmi d’armamento. Tutte e tre le campagne convergono su un obiettivo comune: trasformare le priorità politiche, investendo in sicurezza umana e pace positiva invece che in armi.
Solo una mobilitazione dal basso, informata, diffusa e determinata può aprire la strada a un cambio di rotta: sottrarre l’Europa e l’Italia alla spirale del riarmo e restituire centralità a politiche che proteggano davvero la vita delle persone. Perché la sicurezza non si compra in armi, si costruisce investendo in pace.