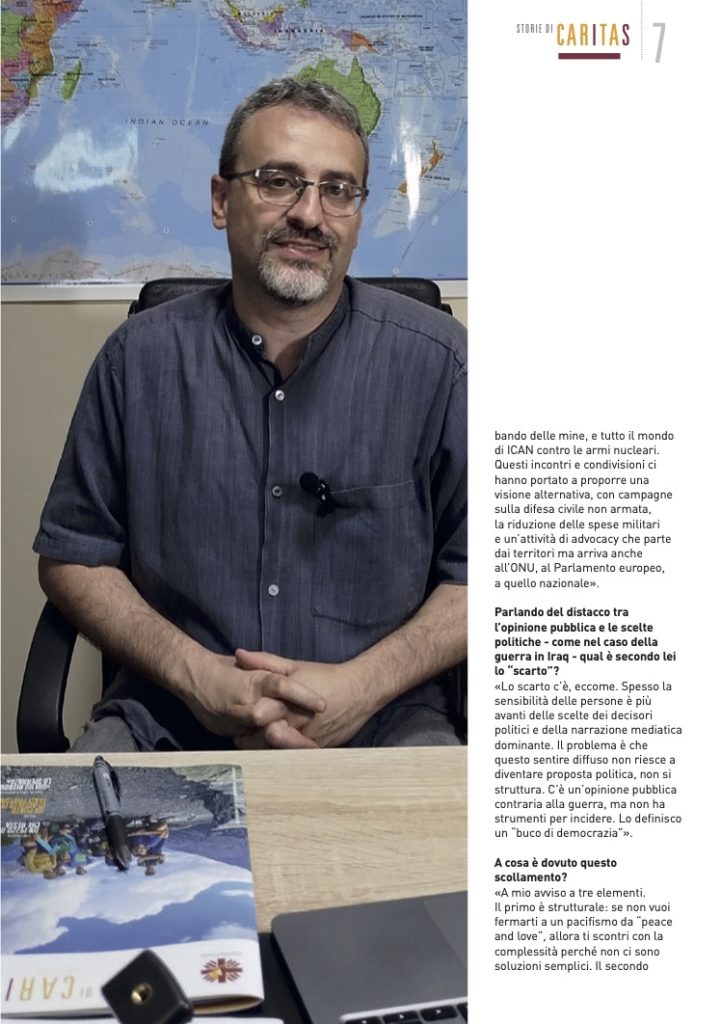Comasco di Olgiate, da circa venti anni si occupa di pace e disarmo oltre che di politiche nonviolente. Nel 2017 con ICAN ha ricevuto il premio Nobel per la Pace. Una mia intervista per “Storie di Caritas”, la rivista della Caritas della Diocesi di Como (a cura di Michele Luppi e Claudio Berni).
Francesco Vignarca è nato a Erba nel 1974. Eupiliese per storia famigliare, oggi vive a Olgiate Comasco con i suoi cari. È sposato con Lucia da 20 anni e ha tre figlie (Lisa di 18 anni, Matilde di 14 e Rebecca di 9 anni). Da circa 20 anni si occupa di pace e disarmo oltre che di politiche nonviolente. È attualmente coordinatore delle Campagne nella Rete Italiana Pace e Disarmo. A Oslo, il 10 dicembre 2017, ha ricevuto il premio Nobel per la Pace assegnato a ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons).
Francesco Vignarca, qual è stato il suo primo impatto con il mondo della nonviolenza e dei cammini di pace?
«Il mio avvicinamento alla nonviolenza è avvenuto gradualmente. Sono cresciuto nella parrocchia di Eupilio, retta dai Barnabiti. Lì, grazie al parroco, c’è sempre stato uno sguardo aperto alle missioni, ma decisivo è stato un viaggio in Brasile nel 1992 quando avevo 18 anni. Quell’esperienza mi ha segnato profondamente: stare accanto ai missionari e vedere da vicino situazioni di ingiustizia, come la polizia federale che sgombra famiglie povere da un fazzoletto di terra a favore di un latifondo enorme, ti cambia lo sguardo. Poi ho partecipato alla Rete Lilliput – che si occupava di mondialità, globalizzazione e giustizia sociale – e a livello locale collaboravo con il Coordinamento Comasco per la Pace».
Lei è laureato in Astrofisica all’Università dell’Insubria e ha conseguito un master in discipline sociologiche all’Università di Milano-Bicocca. Poi il cambiamento del 2003…
«Nel 2003, con la nascita della campagna per difendere la legge 185/90 contro il commercio di armi, mi sono coinvolto sempre di più. Mi hanno proposto di coordinare la neonata Rete Disarmo. Dal 2021, la Rete Disarmo si è fusa con la Rete della Pace, dando vita alla Rete Italiana Pace e Disarmo, un percorso cominciato nel 2014 con l’Arena di Pace e Disarmo a Verona. Negli anni ho capito che se vuoi rendere efficace quell’impegno, devi acquisire competenze, approfondire, proporre soluzioni concrete».
Quali sono stati i momenti decisivi e le figure di riferimento lungo questo percorso?
«Il biennio 2001-2003 è stato fondamentale. Prima il G8 di Genova, poi l’11 settembre e infine la guerra in Iraq: uno stravolgimento totale. Fino agli anni ’90 si parlava di “dividendi della pace”, si riducevano le spese militari, sembrava aprirsi un futuro cooperativo. E invece, in due anni, è cambiato tutto. Le manifestazioni contro la guerra in Iraq, con 3 milioni di persone in piazza a Roma, sono state grandiose, ma poi il governo ha deciso comunque di intervenire. Ci siamo chiesti: a cosa serve mobilitarsi, se non riusciamo a influenzare davvero le decisioni? Da lì è nata la consapevolezza che non bastano le spinte etiche o simboliche. Serve competenza. Nel tempo ho letto e approfondito figure fondamentali: don Lorenzo Milani, don Primo Mazzolari, Giovanni XXIII con la Pacem in Terris, Paolo VI e la Populorum Progressio. E poi Alex Langer, esempio di politica autentica, e tanti compagni di strada nei nostri movimenti».
E poi l’impegno a livello internazionale…
«Ci sono stati altri incontri fondamentali: Jody Williams, premio Nobel per la messa al bando delle mine, e tutto il mondo di ICAN contro le armi nucleari. Questi incontri e condivisioni ci hanno portato a proporre una visione alternativa, con campagne sulla difesa civile non armata, la riduzione delle spese militari e un’attività di advocacy che parte dai territori ma arriva anche all’ONU, al Parlamento europeo, a quello nazionale».
Parlando del distacco tra l’opinione pubblica e le scelte politiche – come nel caso della guerra in Iraq – qual è secondo lei lo “scarto”?
«Lo scarto c’è, eccome. Spesso la sensibilità delle persone è più avanti delle scelte dei decisori politici e della narrazione mediatica dominante. Il problema è che questo sentire diffuso non riesce a diventare proposta politica, non si struttura. C’è un’opinione pubblica contraria alla guerra, ma non ha strumenti per incidere. Lo definisco un “buco di democrazia”».
A cosa è dovuto questo scollamento?
«A mio avviso a tre elementi. Il primo è strutturale: se non vuoi fermarti a un pacifismo da “peace and love”, allora ti scontri con la complessità perché non ci sono soluzioni semplici. Il secondo elemento è che le condizioni economiche e sociali delle persone sono peggiorate. Se fai fatica ad arrivare a fine mese, è normale che ti sembri lontano e irrilevante il tema della pace internazionale. Il terzo elemento è ancora più subdolo. Oggi il messaggio dominante è: “Ma chi te lo fa fare? Tanto non cambia niente, è tutto uno schifo, la politica è tutta uguale, pensa a te stesso”. Questo scoraggia profondamente, e lo si vede anche nella disaffezione al voto. È un meccanismo funzionale a chi vuole mantenere i propri privilegi: non ti convinco che ho ragione, ti convinco che tanto non vale la pena combattere».
Vent’anni fa avrebbe mai immaginato che saremmo arrivati alla situazione che viviamo oggi?
«Non avrei pensato a un riarmo così massiccio e a una retorica militarista così esplicita, in cui la guerra viene utilizzata senza neppure il paravento del diritto internazionale. Oggi si fanno dichiarazioni come quella del cancelliere tedesco Merz, che dice riguardo all’Iran: “Israele sta facendo il lavoro sporco per noi”. Significa che il diritto internazionale non conta più nulla. Non mi piace però oggi parlare di “riarmo”, perché le spese militari crescono dal 2001. Quando nel 2013 abbiamo lanciato l’iniziativa umanitaria contro le armi nucleari, ci dicevano: “Siete solo dei pacifisti in cerca di cause”. E invece, con la campagna ICAN siamo arrivati nel 2017 al Trattato sulla proibizione delle armi nucleari. Papa Francesco ci ha chiamati in Vaticano e ha modificato anche la dottrina morale cattolica: prima era peccato usare l’arma nucleare, dopo è diventato peccato anche possederla. Una svolta».
Altro punto: il minore controllo e la minore trasparenza su produzione ed esportazione di armi. Penso alla legge 185, alla questione delle “banche armate”…
«Cercano di oscurare, abbassare la trasparenza. Noi invece con l’Osservatorio Mil€x, raccogliamo, analizziamo e pubblichiamo le spese militari che fino a pochi anni fa erano nascoste in altre voci di bilancio. Perché se io non ho informazioni sulla spesa militare o sull’export di armi, non posso mostrare che l’Italia, mentre parla di pace e democrazia, vende armi a Paesi autoritari o in guerra».
Si è mai chiesto: “Chi me l’ha fatto fare?”
«No, io credo che quello che facciamo abbia senso. E ha anche prodotto dei risultati. Siamo riusciti a contribuire a due trattati internazionali: uno sul commercio delle armi e uno sulla messa al bando delle armi nucleari. Non hanno ancora risolto i problemi, certo. Ma il fatto che esistano è cruciale. Perché finché non esistono, qualcuno può sempre dire: “Sarebbe bello un mondo senza armi nucleari, ma non c’è nessuna legge, nessun documento, nessuna regola che va in quella direzione”. Invece oggi c’è un trattato. Vuoi rifiutarlo? Allora è una tua responsabilità, non puoi più dire che non esiste. E poi: siamo riusciti a bloccare la vendita di 20.000 bombe all’Arabia Saudita, che le avrebbe usate per bombardare lo Yemen. Non abbiamo fermato la guerra in Yemen, ma forse l’abbiamo ridotta. Abbiamo anche contribuito a ridurre il numero degli F-35 che l’Italia voleva acquistare: da 131 a 90 con un notevole risparmio per le casse dello Stato. Non è zero, ma è qualcosa».
«LA CHIESA ASCOLTI IL PAPA»
Abbiamo chiesto a Francesco Vignarca quanto, dal suo punto di vista, le nostre comunità cristiane siano in linea con la sensibilità sul tema della pace espressa dai pontefici: da Giovanni XXIII a Leone XIV. «Anche nella Chiesa italiana valgono le stesse tre fatiche che vedo nella società», spiega Francesco Vignarca, ritratto nella foto durante l’incontro con Papa Leone XIV, a maggio, in occasione dell’udienza privata con i Movimenti popolari, tappa del percorso di “Arena di Pace”. «A queste si aggiungono alcune fatiche specifiche delle nostre comunità. Primo: la difficoltà a far capire che fede e vita non possono essere separate. Io ho avuto la fortuna di avere come guida spirituale don Bruno Maggioni, che ci diceva sempre: “Sul comodino dovete avere il Vangelo e il giornale. Perché il Vangelo senza il giornale non serve a niente. E il giornale senza il Vangelo non ti fa capire davvero cosa sta succedendo”. Questo però non avviene dappertutto. Il secondo elemento è la crisi delle comunità e delle parrocchie: in termini di partecipazione, presenza, vitalità. Il terzo punto è la sensazione di irrilevanza. Per molto tempo, la Chiesa italiana ha avuto una forte influenza sulla politica. Ma non sempre l’ha esercitata in coerenza con il magistero evangelico: spesso è stata una questione di potere, di numeri, di visibilità mediatica. Invece di promuovere giustizia e pace, si è spesso limitata a difendere interessi interni, piccoli privilegi. E questo ha allontanato molte persone, che hanno percepito la Chiesa come un centro di potere, non come una comunità profetica».